Tracce romane
Attorno al 16/15, truppe romane dell'Imperatore Augusto si spinsero verso nord. L'operazione d'assedio avvenne da parte dei condottieri Tiberio e Druso dalla Gallia e dal Trentino. Una terza unità potrebbe essere partita da Como ed essere avanzata attraverso il passo del Settimo, la Val Sursette e la valle del Reno alpino. Gli armamenti ritrovati ne sono una prova, in particolare le pallottole di piombo sul Settimo e nella regione del Crap Ses.Lo scopo della campagna militare consisteva certamente nel controllo dei passi alpini e nella creazione di basi al nord delle Alpi.
Solo attorno alla metà del primo secolo dopo Cristo venne fondata una Provincia Raetia con capoluogo
Augusta. Attorno al 300, la Provincia venne suddivisa in Raetia prima (probabilmente con capoluogo Coira) e in Raetia secunda (capoluogo Augusta).
Con la conquista da parte dei Romani si assistette a un importante cambiamento culturale. Le tradizionali costruzioni in legno vennero sostituite da grandi costruzioni in pietra con la tecnica della calce spenta.
Fino al giorno d’oggi a Coira sono state rinvenute le fondamenta di circa 25 edifici romani. C’erano un mercato e un bagno pubblico, verosimilmente anche un teatro e un tempio. Le dimensioni esatte della città romana di Curia non sono tuttavia ancora note
Nel 1986, una parte degli scavi romani di Coira sono stati ricoperti da strutture protettive ideate dall’architetto grigionese Peter Zumthor. Sono accessibili al pubblico e possono essere visitati a livello individuale. La chiave è reperibile presso la ricezione del Museo retico.
Mercurio e Diana
Mercurio, la divinità romana del commercio e degli scambi, era sempre rappresentato in modo simile: in mano un bastone, ai piedi delle scarpe alate e sul capo un cappello anche lui alato. Proprio il copricapo alato permette di riconoscere Mercurio nella nostra statuetta, ritrovata a Coira tra i resti di un edificio bruciato risalente all'epoca romana. Quasi duemila anni fa questa figura ornava l'altare domestico di una casa d'abitazione, insieme a un’altra figura, Diana, la dea della caccia.
La cultura romana si diffuse nell'arco alpino dopo la conquista da parte dei Romani, avvenuta nell'anno 15 a.C. Non solo se ne veneravano le divinità, ma se ne adottò la lingua, si mangiavano cibi mediterranei da stoviglie in terra sigillata rossa e si pagava con monete romane.
Coira divenne un importante centro commerciale e infine capitale della provincia Raetia. Qui si trovavano costruzioni in pietra dotate di riscaldamenti romani ad aria calda e dipinti murali, vi erano delle terme e probabilmente anche un mercato e un tempio. Lungo le strade appena ampliate, in particolare lungo il passo dello Julier e del Settimo, sorsero ospizi per viandanti con i loro animali e le loro merci.
I Rezi
I Romani stabilirono la propria provincia «Raetia» dal territorio degli odierni Grigioni fino alla Bavaria. In epoca tardo-romana, Coira divenne la capitale della provincia. È probabilmente per questo motivo che Coira viene associata fino ad oggi alla «Rezia»
Carlo Magno sull'Umbrail
Secondo la leggenda, Carlo Magno fu sorpreso da una forte bufera di neve sul passo dell’Umbrail. Grato per essersi salvato, avrebbe fondato il monastero di San Giovanni. Il ritratto del benefattore sull’urbarium, risalente al 1394, mostra come l’imperatore offra il monastero, rappresentato da un modello architettonico, a San Giovanni.
La statua posta in una nicchia della parete dell’abbazia rappresenta Carlo Magno. Probabilmente, in origine l’imperatore teneva un modello del monastero tra le mani. Grazie ai suoi affreschi carolingi e romanici, l’abbazia oggi è famosa in tutto il mondo.
Armatura massimilianea
Lucerna, intorno al 1525
Un’armatura non può mancare in un museo storico. Anche i responsabili della collezione di allora erano di questo avviso. L’acquisizione di questo ambito oggetto si rivelò tuttavia difficile, perché nei Grigioni non si erano praticamente conservate armature. Ecco perché rivolsero la ricerca al di fuori del Cantone e trovarono infine un oggetto presso una collezione privata di Lucerna. Tutta l’armatura massimilianea costò ben 1500 franchi, un prezzo estremamente elevato per quei tempi.
La superficie scanalata di questa armatura degli inizi dell’epoca moderna offriva maggiore protezione contro i proiettili delle nuove armi da fuoco allora emergenti.
Memento mori
Se non ho il memento mori non sono contento
Piastrella di una stufa a torre che rappresenta l'ultima fase della vita
Probabilmente Germania meridionale, 1a metà del XVII secolo
Nel tardo Medioevo, le stufe chiuse, accese dall’esterno, andarono a sostituire i caminetti nei salotti delle case borghesi e contadine. Nei Grigioni si trattava di stufe in pietra ollare o maiolica, create con piastrelle come questa. Le parti esterne di queste mattonelle erano smaltate con vari colori e spesso venivano decorate anche con rilievi o dipinti.
Sulla nostra piastrella è raffigurato un anziano seduto, accanto a lui la morte è già bene in vista. Raffigurare le varie tappe della vita era tipico del tardo Rinascimento. La figura della morte con la clessidra in mano ha la funzione di ricordare la caducità della vita.
Portone di una chiesa Luzein, intorno al 1670
Dal punto di vista di un museo, è sempre preferibile che un edificio si conservi al completo, con tutte le sue componenti originali. Nella pratica questo però non è sempre possibile. Sia perché una casa venga demolita, che alcuni elementi debbano far spazio a una ristrutturazione o che un oggetto rischi di subire danni per esempio a causa di agenti atmosferici. In casi simili, gli elementi architettonici possono anche entrare a far parte della collezione.
È quel che è successo a questo portone di una chiesa ad arco ogivale in legno di larice, trasferito nel 1930 «per precauzione», come fu scritto, da Luzein al museo. Per la chiesa del luogo ne fu realizzata una copia.
Tesori di monete
Ritrovamento di monete risalenti al tardo Medioevo
Stampa-Maloja, 1333‒1390
Non lontano dal punto più alto del passo del Maloja, alcuni bambini trovarono uno dei tesori di monete più importanti mai rinvenuti nei Grigioni. Si trattava di due contenitori di legno, contenenti 6 monete d’oro e 362 d’argento, che furono rapidamente vendute a diversi acquirenti. A posteriori, il museo è riuscito a ricomprare tutte le monete e a riunirle nella collezione.
Il ritrovamento riguarda principalmente monete lombarde provenienti da Milano e Pavia. Alcune provengono da Genova, Venezia e dalla Germania meridionale.
Come la maggior parte dei ritrovamenti di monete del tardo Medioevo della collezione, anche le monete del Maloja sono state rinvenute accanto a un importante valico alpino. Potrebbero essere appartenute a un viaggiatore o un commerciante.
Statua per fontana
Statua per fontana Valendas, 1760
Nella piazza di Valendas si trova una delle fontane lignee più grandi d‘Europa. La vasca misura 4,8 metri per 12 e in cima alla colonna siede una sirena con un cappello di paglia di Firenze. È una copia - nel 1953 l’originale del 1760 è stato trasferito nella raccolta del museo per conservarla. Aveva risentito sempre più degli agenti atmosferici.
Attorno alla statua e alle sue origini circola ogni sorta di leggende. Secondo i documenti di acquisizione del Museo è stata donata dal colonnello Johann Peter Marchion (1695‒1766). La statua sarebbe stata intagliata da Hans Bonadurer (1717‒1788), artigiano del luogo, ma non è più possibile verificare queste informazioni.
Soldatini di piombo
Soldatini di piombo, reggimento «von Buol», intorno al 1730
Zurigo, intorno al 1900
I soldatini di piombo nel XIX secolo erano fra i giocattoli più amati dai bambini. Si potevano comprare oppure fare da sé con una colata di una lega di stagno e piombo per poi pitturarli. Questi giocattoli finivano inoltre per rispecchiare anche le guerre reali, come successe, per esempio, con la guerra franco-prussiana del 1870/71, la quale portò a una copiosa produzione di soldatini di piombo a essa ispirati.
Le nostre piccole figure rappresentano il reggimento «Buol» al servizio dell’esercito austriaco. Il suo titolare Anton von Buol (1671–1717) proveniva da una delle principali famiglie di mercenari dei Grigioni. Il reggimento contava 1600 uomini e fu operativo in Tirolo e in Italia.
Macchina per ravioli
Macchina per ravioli del pastificio CaDa
Coira, intorno al 1940
La fabbrica di «fidelini» di Coira, fondata nel 1841, fu uno dei primi pastifici della Svizzera e una delle poche attività industriali del cantone dei Grigioni. Quando Johann Caprez-Danuser rilevò l’azienda tra la Sägenstrasse e la Salvatorenstrasse nel 1901, dal suo nome nacque la ditta CaDa. Il pastificio di Coira rimase nelle mani della famiglia per tre generazioni. Nel 1997 la fabbrica si tramutò nella Frigemo Produktion Chur AG finché non chiuse i battenti nel 2006, dopo ben 165 anni di attività.
Questa raviolatrice manuale fu utilizzata per decenni per produrre ravioli freschi, che dalla fabbrica raggiungevano ristoranti, alberghi, negozi e privati.
Volantino del 1726
Volantino relativo al secondo capitolato di Milano
Luogo ignoto, intorno al 1726
Libertas suspensa – «La libertà è sospesa». In questa sequenza di immagini comiche si incolpa l’autorità di aver svenduto gli interessi grigionesi e di corruzione.
Questa bozza di volantino critica il «capitolato di Milano», concluso nel 1726 tra le Tre Leghe e l’Austria. Con questo trattato si rinnovavano i patti politici, economici e religiosi sanciti già con il primo capitolato del 1639. Questo divideva le Leghe, poiché minacciava la cacciata dei protestanti dal territorio suddito di Chiavenna. Soprattutto i seguaci dei Salis, ostili all’Austria, erano contrari al trattato. Che l’anonimo disegnatore di questo volantino facesse parte delle loro file?
Giustizia
Personificazione di Justitia, la dea della giustizia, proveniente dal municipio di Coira, 1600 ca.
Nelle mani le insegne della bilancia e della spada, ma non bendata.
Legno di tiglio, intagliato, incastonato e dorato.Stemma della città di Coira.
Lavorazione del metallo
Per migliaia di anni sono stati sfruttati i diversi giacimenti minerari delle montagne grigionesi. L'attività mineraria offriva alla popolazione una gradita fonte di reddito supplementare.
Le scorie e i reperti metallici rinvenuti nei siti di insediamento dell'Età del Bronzo (lab.
I siti di insediamento dell'Età del Bronzo (2000 a.C.) dimostrano che l'estrazione e la lavorazione del rame erano praticate. Nei Grigioni si trovano prove di fusione del ferro già prima dell'epoca romana.
L'attività di fabbro raggiunse il suo massimo splendore a partire dal XV secolo.
XV secolo. Si producevano serrature finemente cesellate, cerniere, grate, banderuole ecc.
Non meno di nove officine monetarie erano attive sul territorio grigionese.
Gronda in lamiera nera, seconda metà del XVII secolo, Coira
Banderuola in ferro, 1650, Zizers
Oggetti dal mondo contadino
Asta usata per calcolare la quantità di latte prodotta sull'alpe
Tujetsch, intorno al 1900
Un tempo, gli agricoltori di Tujetsch gestivano l’Alpe Cavorgia autonomamente, secondo turni prestabiliti. Ai fini del calcolo, la quantità di latte prodotta da ogni contadino veniva misurata quotidianamente per mezzo di tacche apportate su un’asta di legno pluriangolare dipinta di rosso.
All’epoca si usava l’antica misura di peso della Krinne (1 Krinne = 5/8 kg). A metà dell’asta erano incise, su due file, le insegne dei proprietari. La domenica, dopo la messa gli agricoltori si occupavano della fattura del latte e la liquidavano tagliando via le indicazioni relative al peso. A partire dal 1901, sull’Alpe Cavorgia l’asta del latte venne sostituita dalla fattura cartacea.





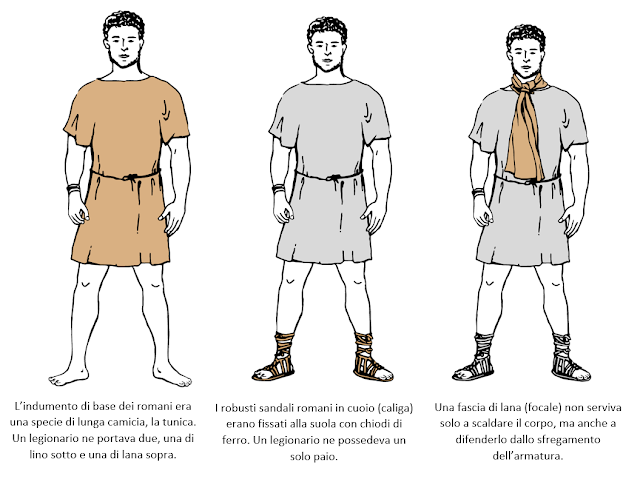

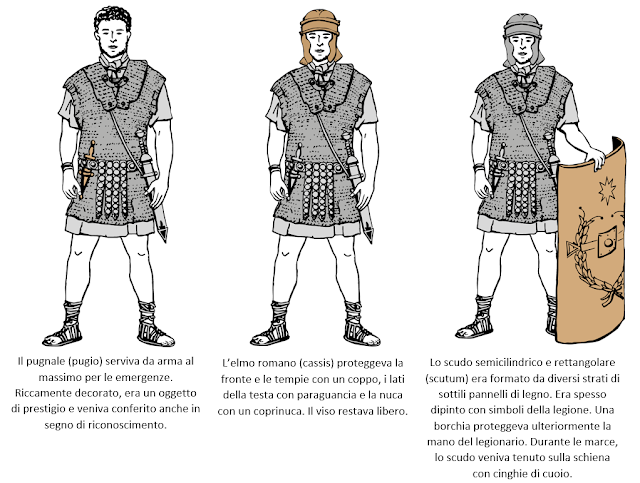























Commenti
Posta un commento