Ho sempre pensato (con largo anticipo e per diletto) come investire il mio tempo una volta pensionato. Per prima cosa mi sono divertito ad osservare cosa fanno i pensionati al giorno d'oggi: le attività variano dai classicissimi lettura del giornale, passeggiata al fiume ritrovo al bar / parchetto con altri pensionati.
Po ci sono attività che includono più tempo incluso una certa attività fisica, cura dell'orto, ristrutturazione della cascina, ristrutturazione della cascina, ristrutturazione della cascina, fare legna, ristrutturazione della cascina, ristrutturazione della cascina.
Nascosto tra le mille ristrutturazione della cascina (attività suprema da queste parti) ho inserito fare legna. Non conosco moltissimi pensionati che fanno legna, ma quelli che la fanno...oh, non vanno di certo per il sottile. Evidentemente questa materia prima una volta era di basilare importanza, specialmente per quel che riguarda la legna da ardere, per far carbone o per le costruzioni. Eccomi dunque pronto per un magico viaggio attraverso l'oro delle montagne
Moto scaramantico
La ragione per cui molta gente di vari paesi tocca legno per aver fortuna risale ai tempi in cui si adoravano divinità silvestri.
Toccare o bussare sugli alberi era un modo di chiedere protezione agli spiriti che vi risiedevano.L'albero più sacro era la quercia, specie per i druidi quando vi cresceva su il vischio.
Il rituale di toccar legno fu ripreso nei tempi cristiani, quando si cercava lo stesso tipo di protezione toccando i supposti pezzi della "vera croce" su cui Cristo era stato crocefisso.
La chiese offrivano asilo contro l'arresto o l'esecuzione ai fuggitivi che avevano toccato il legno dei loro portali.
Motivo di faida nelle saghe islandesi
Che fosse un bene prezioso già dai tempi antichi lo si deduce leggendo questa novella islandese, dove il casus belli é proprio della legna.
Da pochi tronchi la disputa si allarga, fino a riguardare intere proprietà agricole. Snorri non si fa scrupolo ad uccidere l'uomo, cogliendolo di sorpresa mentre lavora nei campi, né di far cadere la colpa su uno dei suoi stessi compagni, Thorleif.
Illustrazione di Snorre Sturluson di Christian Krogh da Heimskringla, edizione 1899
Faura l'oro montano
In epoca pagana c’era un vero e proprio culto degli alberi, con zone boschive in cui non si poteva nemmeno raccogliere un rametto e, racconta l’antropologo James G. Frazer nel Ramo d’oro, in alcune parti del mondo c’erano boschi trattati come se fossero donne incinte. Come spesso accade, queste pratiche dall’apparenza «magica» avevano un fondamento ben radicato nella realtà: i boschi sopra i villaggi andavano custoditi con cura se si voleva sopravvivere. Il bosco protegge dalle frane, dalle valanghe, e se è ben conservato può servire in caso di catastrofe, perché costituisce una riserva di legname, mangime per gli animali e cibo per gli uomini; nel bosco possono anche esserci fiumi e sorgenti da preservare; ci sono i funghi, il fieno selvatico e l’erba; le conifere protette spesso fanno anche da barriera per salvare altri alberi utili come il castagno.
Regolamentazioni Svizzera del Medio Evo
A partire dal basso medioevo vennero promulgate ordinanze di vincolo (le cosiddette Bannbriefe) allo scopo di sottrarre determinati Boschi, aree boschive o singole varietà arboree all'uso corrente e generalizzato, rispettivamente per riservarle a persone o cerchie ben definite.
Strettamente legata al concetto di bosco sacro è la funzione protettiva dei boschi di montagna contro i pericoli naturali, fondamentale per molte vallate montane. Accanto alla difesa contro la caduta di massi e le Valanghe un ulteriore elemento di rilievo era costituito dalla gestione locale dell'utilizzazione del bosco, in modo da ovviare alla penuria di legna.
Il bisogno di assicurarsi la legna per determinati scopi e la funzione di salvaguardia erano frequentemente collegati; il patrimonio boschivo protetto lungo torrenti e fiumi permetteva da un lato di consolidare le rive e dall'altro di garantire la scorta di legna necessaria alle costruzioni. Le ordinanze di vincolo più antiche di cui si ha conoscenza provengono dall'antica terra di Svitto e dalle vallate del canton Uri; in primo piano vi era, ad esempio, nella zona del lago di Lauerz, la disciplina dell'uso (1337), nella valle della Muota la difesa delle sponde (lantweri; nuovamente nel 1343) e il divieto di carbonizzazione (1339), a Flüelen la difesa dalle frane (1382) e ad Andermatt la difesa dalle valanghe (1397).
A partire dal XV secolo le bandite boschive divennero numerose: nell'area alpina prevalentemente con funzioni di protezione, nell'Altopiano come strumento di regolazione dello sfruttamento (legna, pascolo, strame, rami, resina). La prima legge forestale federale (1876) non contemplò il concetto, ormai diffuso, di bosco sacro, cui venne preferito il termine di bosco protettivo.
Il mese di gennaio. Illustrazione all'acquaforte tratta dalla descrizione dei 12 mesi e dei loro lavori, incisa nel 1663 da Conrad Meyer (Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv).
Nel mese di gennaio si raccoglieva e si preparava la legna da ardere. Chiunque poteva rifornirsi di legna morta nei boschi.
La faura
Le prime testimonianze scritte di boschi protetti nel Cantone Ticino risalgono al tredicesimo secolo, negli statuti di Brissago con il termine di fabula iurata e negli stessi anni iniziano i decreti anche in tutti gli altri cantoni alpini della Svizzera.
In Ticino si sono dati vari nomi, soprattutto dopo che le regolamentazioni sono diventate scritte e precise. faura è il nome più bello: viene da fabula, che in latino significa parola, e per estensione patto, norma, divieto. Uno dei decreti ufficiali più severi e articolati che ci sono stati tramandati è quello della faura sopra Airolo, risalente al Settecento. Visto che il bosco era ciò che di più prezioso le popolazioni dei villaggi avevano in quei tempi, la legge per antonomasia era quella che regolava il rapporto tra uomo e bosco.
Ci sono altri nomi, per esempio faula in Valle Maggia, fabra in Valle di Blenio, mentre nel Sottoceneri si trovano maggiormente i termini gaggio o tensa. «Bosco sacro» è invece una definizione che spunta nei documenti comunali ottocenteschi, quando il bosco protetto diventa, con un cambio di prospettiva, il bosco che protegge; in quegli anni se ne parlò moltissimo a causa di un eccessivo disboscamento che si andava verificando nelle valli. «Anche ai nostri giorni diamo lo stesso valore al bosco sacro, come un tempo», assicura Roland David, capo della Sezione Forestale del Canton Ticino. «Si considera che l’80% delle nostre foreste abbia una funzione di protezione e il 40-45% in modo diretto, perché si trova proprio sopra ai villaggi. Di diverso rispetto al passato c’è però che le regolamentazioni non sono più a livello comunitario bensì cantonale e federale».
Il rasatore
C’è un’altra parola bellissima legata al bosco: la manna. La manna, sostanza piena di proprietà curative e nutritive, si estrae in Sicilia dal frassino; da noi, dentro ai boschi sacri si prendeva invece la resina dai larici, dagli abeti rossi e da quelli bianchi e poi la si trasformava in trementina e pece. Il lavoro iniziava nei mesi primaverili al momento della ripresa del ciclo vegetativo: con un’accetta si intagliava il tronco e la linfa colava per mesi in recipienti di corteccia o di vimini legati all’albero. A contatto con l’aria la linfa si solidificava. Il rasatore (questo il nome del mestiere, in siciliano il mannaruolo) la faceva seccare ulteriormente nel bosco, facendola cuocere in recipienti d’argilla. Il prodotto veniva poi venduto a fabbricanti di sapone, osti, birrai, cordai, calzolai, carrettieri, droghieri, o nei cantieri navali per calafatare le navi.
Il bosco dà funghi, mirtilli, fieno selvatico, linfa, legna e protezione invernale: deve avere il suo equilibrio per crescere forte in certi punti e può servire d’inverno per far pascolare le capre. Ancora oggi si distingue tra bosco protettivo e altre aree boschive e una delle sfide più importanti delle politiche forestali è come conciliare tutte le funzioni del bosco; figuriamoci quando le sue risorse erano essenziali per la vita quotidiana.
Alina Borioli, poetessa di Ambrì, che ha intitolato Vos det la Faura una raccolta di sue poesie in dialetto; riguardo a questo termine scrive che in Leventina c’era un detto: Ves sü par la faura, per indicare una donna incinta, come a dire che anche lei in quel momento costituiva un luogo protetto.
Vanni Bianconi, poeta di Locarno ma anche lui leventinese di Ambrì per parte materna, ha scelto la foresta per parlare del suo percorso di scrittura, nella sua prima silloge di poesie: La Faura dei morti, luogo tra qui e là, confine misterioso dove non ci si addentra, pena la morte. Ma la morte del poeta, così come la morte dell’uomo pagano, è solo un viaggio, un cambio di pelle, un andare di là per sapere qualcosa in più.
Denunce furti di legname
Capito abbastanza di frequenta in archivio cantonale a Bellinzona. Spulciando i processi civili pretore di Leventina mi imbatto a partire dalla fine del 1870 in una crescente presenza di reati forestali. Ne riporto un paio ad esempi
Senza troppi giri di parole si fa nome e cognome delm colpevole e dalla serie di domande si ricostruiscono gli eventi
Interessante la lista che riporta esattamente quale e quante legname fosse oggetto del furto
Malgrado la precisione della lista l'accusatore si riserba di andare a controllare meglio con la bella stagione
"Stante la quantità di neve caduta in quella località essendomi impossibile procedere al confronto e controllo delle piante tagliate, mi riserbo di produrre constatazione precisa della contravvenzione l'anno venturo appena il terreno sarà sgombro"
Un secondo esempio riguarda sempre la valle Bedretto ma l'accusato (Maurizio Forni di Bedretto) alla fine si difende sostenendo che per la legna in suo possesso aveva avuto l'ok delle autorità municipali. Nello specifico gli necessitava per la "riattazione di una casa a fabbricarsi"
Lo sfruttamento del bosco nel Ticino dell'800
Il territorio del Ticino, fatto in gran parte di montagne, rocce e valli dirupate, non offriva molte risorse agli abitanti, era ricco di pietre e di foreste, ma povero di minerali utili all'industria, e concedeva scarsi spazi all'allevamento e all'agricoltura.La sola vera ricchezza, sfruttata da secoli, era l'imponente patrimonio forestale, che nei primi decenni dell'Ottocento era diventato ancora piú ambito che in passato.
Già le poche industrie che tentarono di sfruttare le risorse minerarie del paese erano state attirate piú dall'abbondanza di combustibile disponibile sul posto che dalla ricchezza o dalla qualità dei giacimenti, e quando gli stabilimenti avevano ridotto i boschi dei dintorni in cenere, di solito chiudevano i battenti.Non stupisce che si cominciasse a lamentare la penuria e il prezzo esorbitante del combustibile e che nel 1841 alcuni fabbri e proprietari di magli e fonderie chiedessero al parlamento di limitare le esportazioni di carbone di legna, altrimenti avrebbero dovuto cessare le loro attività
Quasi tutti i boschi appartenevano ai patriziati che, allettati dai grandi guadagni, ne vendevano il taglio fino all'ultima risorsa, senza badare alle conseguenze negative: Gli speculatori denudavano le montagne, degradando pregiate foreste a misere boscaglie cespugliose, esponendo i pendii all'erosione e alle frane, e gli abitati alle valanghe e alla furia dei torrenti.
Boscaioli che trasportano a valle un carico di legna
Riproduzione della stampa tratta da: Alexandre Martin: La Suisse pittoresque et ses environs. Tableau général, descriptif, historique et statistique des 22 cantons, de la Savoie, d'une partie du Piémont et du pays de Bade. Parigi: Hippolyte Souverain, 1835.
Collezione ETH-Bibliothek Zürich, Alte und Seltene Drucke
Il taglio di un bosco e il trasporto del legname erano operazioni complesse, faticose e assai rischiose che impegnavano per mesi alcune centinaia di lavoratori specializzati. Venivano reclutati a squadre nelle montagne del Verbano, dell'Ossola, del Comasco, della Valtellina e nelle valli bergamasche, perché la mano d'opera locale non bastava. Boscaioli e borratori trovavano riparo nei fienili o si accampavano nei boschi, fabbricandosi capanne di travi e frasche, dove stendevano i loro pagliericci di foglie secche, felci o fieno. I mercanti li rifornivano di farina di mais, formaggio, sale, pane, vino e acquavite e procuravano le capre per far loro avere anche il latte: i comuni concedevano di solito il pascolo nel bosco a tante capre quanti erano i lavoratori.
Le vendite di boschi procuravano ai patriziati entrate ingenti che spesso venivano spartite in modo imprevidente, iniquo e litigioso, invece di servire per estinguere i debiti o per realizzare opere di comune utilità.
L'intervento del governo indusse effettivamente parecchie comunità a utilizzare le entrate forestali per costruire scuole, o argini e risanare le finanze, ma non mancarono i patriziati che preferirono ignorare la legge e restare, come fu detto, con qualche bosco in meno e qualche debito in piú.
Il legname mercantile giunto al lago, legato in zattere di fronte al porto di Locarno a Rivapiana, è trattenuto dalle «roste» prima di proseguire la navigazione (Disegno acquarellato a seppia di Peter Birmann (1758-1844), Locarno sur le Lac Magior. 1807, Basilea, Offentliche Kunstsammlung, Kupferstichkabinett).
Fatta una legge per favorire il libero commercio dei legnami, e con quello i tagli a tutto spiano, ecco che poi l'autorità s'accinse a prepararne un'altra che andava in senso opposto, per la tutela e il buon governo dei boschi: l'impulso era venuto dalla terribile alluvione del 1839, che aveva provocato danni per quasi un milione e mezzo di franchi, imputati da un perito della Confederazione al delittuoso scempio forestale.
Immagine significativa al cimitero Airolo
Anche i cimiteri non sono immuni alle mie visite. In particolare in quello del mio domicilio l'occhio mi cade su una foto di un loculo. In essa un uomo di avanzata età che gaudente porta in grembo diversi pezzi di legna appena tagliata. Il viso é raggiante.
Accatastamento della legna
Collegati alla legna deversi mondi, uno dei quali, forse uno dei più particolare a vedersi, quello dell'accatastamento della legna.
Anche in dettagli come questo si possono intravedere delle differenze culturali e di mentalità sostanziali presenti in Svizzera: dallo svizzero tedesco più quadrato e ligio al ticinese più estroverso e meno propenso alla perfezione
Werdenberg San Gallo
Sonlerto - Valle Bavona







.jpg)


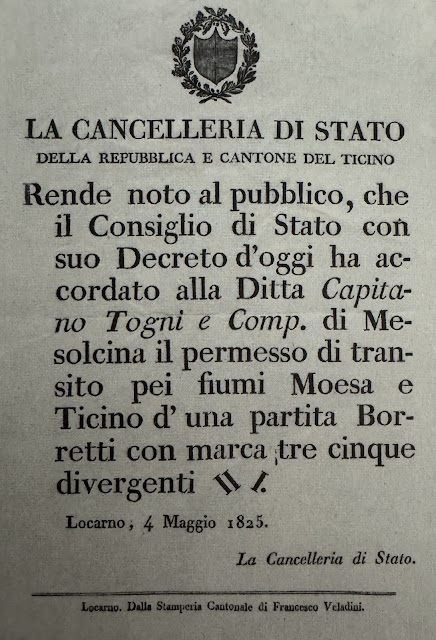






Commenti
Posta un commento